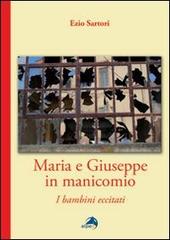Maria e Giuseppe: l’infanzia in manicomio. Storie di bambini eccitati
 “Quando ero in manicomio, e vedevo l’erba dalla parte delle radici, ero convinta (e ancora lo sono) che il grande arazzo della volontà divina lo vedano gli angeli, mentre noi, incamminati verso l’indolenza o il sacrificio estremo, non comprendiamo nulla”. Così Alda Merini, poetessa malgrado il manicomio. Chissà se avranno mai guardato fili d’erba e che emozioni gli avranno dato, cosa avranno sentito, pensato, come avranno percepito il vivere i 2761 bambini ricoverati al manicomio del Santa Maria della Pietà di Roma tra il 1914 e il 1974, 60 anni di storia italiana appena lasciata alle spalle. Bambini costretti al silenzio, reificati, a cui è stata tolta la possibilità d’esistere, in alcuni casi diventati anziani in manicomio, oppure morti precocemente, quasi mai tornati a vite “normali”. Ha ridato voce a questi nostri fratelli e sorelle maggiori del secolo scorso “incamminati verso il sacrificio estremo” quanto folle dell’internamento, immotivato se non funzionale alla logica del controllo e dell’esclusione sociale, Ezio Sartori, pediatra. Da anni Sartori è impegnato a ricostruire un’altra storia della pediatria, a colmare le lacune della storia della psichiatria infantile che è anche storia sociale. Lo ha fatto in un libro di grande interesse e impatto emotivo, Maria e Giuseppe in manicomio – I bambini eccitati (Alpes edizioni) che testimonia una realtà drammatica e quasi mai raccontata. Grazie a una collaborazione con il Centro studi e Ricerche del museo Laboratorio della Mente della Asl Rm E Sartori ha consultato centinaia di cartelle cliniche del prezioso archivio del Santa Maria della Pietà fino a produrre una testimonianza straordinaria che va oltre il freddo studio epidemiologico e restituisce la consapevolezza del privilegio d’ esser nati sotto un cielo senza manicomi e con una maggiore coscienza individuale e collettiva nonché istituzionale dell’universo infantile. Emerge una narrazione in cui come precisa Pompeo Martelli, direttore del Museo Laboratorio della Mente, “a chi sa leggerle queste vite restituite dall’Archivio rivelano una quasi eternità in cui non smettono di dissolversi e di annullarsi”. Ricorda ancora Martelli che “la fonte d’archivio non costituisce una testimonianza ingenua, essa è formattata dall’autorità, per quanto trascini senza volerlo, frammenti di realtà, trasmetta echi di voci spente e di ribellioni stroncate”. Per questo Sartori ha elaborato “un suo personale contro archivio stabilendo a sua volte gerarchie di senso”, lasciando parlare i bambini sia pure con parole di costrizione: quelle di chi è interrogato da un’autorità inaccessibile.
“Quando ero in manicomio, e vedevo l’erba dalla parte delle radici, ero convinta (e ancora lo sono) che il grande arazzo della volontà divina lo vedano gli angeli, mentre noi, incamminati verso l’indolenza o il sacrificio estremo, non comprendiamo nulla”. Così Alda Merini, poetessa malgrado il manicomio. Chissà se avranno mai guardato fili d’erba e che emozioni gli avranno dato, cosa avranno sentito, pensato, come avranno percepito il vivere i 2761 bambini ricoverati al manicomio del Santa Maria della Pietà di Roma tra il 1914 e il 1974, 60 anni di storia italiana appena lasciata alle spalle. Bambini costretti al silenzio, reificati, a cui è stata tolta la possibilità d’esistere, in alcuni casi diventati anziani in manicomio, oppure morti precocemente, quasi mai tornati a vite “normali”. Ha ridato voce a questi nostri fratelli e sorelle maggiori del secolo scorso “incamminati verso il sacrificio estremo” quanto folle dell’internamento, immotivato se non funzionale alla logica del controllo e dell’esclusione sociale, Ezio Sartori, pediatra. Da anni Sartori è impegnato a ricostruire un’altra storia della pediatria, a colmare le lacune della storia della psichiatria infantile che è anche storia sociale. Lo ha fatto in un libro di grande interesse e impatto emotivo, Maria e Giuseppe in manicomio – I bambini eccitati (Alpes edizioni) che testimonia una realtà drammatica e quasi mai raccontata. Grazie a una collaborazione con il Centro studi e Ricerche del museo Laboratorio della Mente della Asl Rm E Sartori ha consultato centinaia di cartelle cliniche del prezioso archivio del Santa Maria della Pietà fino a produrre una testimonianza straordinaria che va oltre il freddo studio epidemiologico e restituisce la consapevolezza del privilegio d’ esser nati sotto un cielo senza manicomi e con una maggiore coscienza individuale e collettiva nonché istituzionale dell’universo infantile. Emerge una narrazione in cui come precisa Pompeo Martelli, direttore del Museo Laboratorio della Mente, “a chi sa leggerle queste vite restituite dall’Archivio rivelano una quasi eternità in cui non smettono di dissolversi e di annullarsi”. Ricorda ancora Martelli che “la fonte d’archivio non costituisce una testimonianza ingenua, essa è formattata dall’autorità, per quanto trascini senza volerlo, frammenti di realtà, trasmetta echi di voci spente e di ribellioni stroncate”. Per questo Sartori ha elaborato “un suo personale contro archivio stabilendo a sua volte gerarchie di senso”, lasciando parlare i bambini sia pure con parole di costrizione: quelle di chi è interrogato da un’autorità inaccessibile.
 È una narrazione partecipata in cui l’espediente di chiamare tutti i bambini di cui sono ricostruite le storie manicomiali Maria e Giuseppe è attuato perché nessuno si senta offeso, nessuno venga discriminato, almeno nella memoria, almeno da morto. Nota Sartori che tra il 1914 (quando fu inaugurata la nuova sede del manicomio romano) e la definitiva chiusura del padiglione pediatrico del Santa Maria della pietà nel 1974, 239 bambini furono internati perché riconosciuti affetti da stato di eccitamento: oggi si direbbe “deficit d’attenzione-iperattività”, sindrome allora non identificata. Il pediatra riemerge dall’appassionata perlustrazione delle cartelle cliniche sorpreso perché in esse non scorge traccia di patologie significative né di condizioni tali di pericolosità per sé e per gli altri da internare bambini anche solo di 3 anni. Allora cosa si nasconde dietro diagnosi che dovrebbero essere il risultato di complesse valutazioni e invece erano generiche? Si nascondono tante storie di povertà e ignoranza, esclusione sociale, discriminazioni, abbandono. Le cartelle cliniche fanno emergere storie di bambini nati sotto cattive stelle e la storia di una particolare comunità autosufficiente che era il manicomio. La struttura romana aveva due padiglioni dedicati all’ ‘assistenza dei minori’: uno per i bambini ‘tranquilli’ o recuperabili che aveva 50 posti; l’altro per i ‘sudici’ o irrecuperabili, con 40 posti. A determinare l’internamento, erano il più delle volte situazioni di difficoltà sociale e familiari, stili di pensiero repressivo, modalità ‘pedagogiche’ coercitive e limitate. Famiglia assente o disgregata a causa della miseria, delle malattie, dell’etilismo, della mancanza di un genitore era condizione sufficiente perché bambini fossero rimbalzati da orfanotrofi, collegi, riformatori fino al manicomio dove era più che ‘naturale’ sviluppare comportamenti reattivi, ribelli, abnormi, fino a tentativi di fuga, in assenza di un sistema capace di garantire davvero protezione e assistenza al minore. Vigeva invece una compatta rete istituzionale quasi sempre di matrice cattolica in cui si rispondeva a un’unica necessità: eliminare chi non fosse funzionale al codice sociale, chi ponesse problemi di difformità, anche fisica, tanto più in anni di autoritarismo e dittatura fascista.
È una narrazione partecipata in cui l’espediente di chiamare tutti i bambini di cui sono ricostruite le storie manicomiali Maria e Giuseppe è attuato perché nessuno si senta offeso, nessuno venga discriminato, almeno nella memoria, almeno da morto. Nota Sartori che tra il 1914 (quando fu inaugurata la nuova sede del manicomio romano) e la definitiva chiusura del padiglione pediatrico del Santa Maria della pietà nel 1974, 239 bambini furono internati perché riconosciuti affetti da stato di eccitamento: oggi si direbbe “deficit d’attenzione-iperattività”, sindrome allora non identificata. Il pediatra riemerge dall’appassionata perlustrazione delle cartelle cliniche sorpreso perché in esse non scorge traccia di patologie significative né di condizioni tali di pericolosità per sé e per gli altri da internare bambini anche solo di 3 anni. Allora cosa si nasconde dietro diagnosi che dovrebbero essere il risultato di complesse valutazioni e invece erano generiche? Si nascondono tante storie di povertà e ignoranza, esclusione sociale, discriminazioni, abbandono. Le cartelle cliniche fanno emergere storie di bambini nati sotto cattive stelle e la storia di una particolare comunità autosufficiente che era il manicomio. La struttura romana aveva due padiglioni dedicati all’ ‘assistenza dei minori’: uno per i bambini ‘tranquilli’ o recuperabili che aveva 50 posti; l’altro per i ‘sudici’ o irrecuperabili, con 40 posti. A determinare l’internamento, erano il più delle volte situazioni di difficoltà sociale e familiari, stili di pensiero repressivo, modalità ‘pedagogiche’ coercitive e limitate. Famiglia assente o disgregata a causa della miseria, delle malattie, dell’etilismo, della mancanza di un genitore era condizione sufficiente perché bambini fossero rimbalzati da orfanotrofi, collegi, riformatori fino al manicomio dove era più che ‘naturale’ sviluppare comportamenti reattivi, ribelli, abnormi, fino a tentativi di fuga, in assenza di un sistema capace di garantire davvero protezione e assistenza al minore. Vigeva invece una compatta rete istituzionale quasi sempre di matrice cattolica in cui si rispondeva a un’unica necessità: eliminare chi non fosse funzionale al codice sociale, chi ponesse problemi di difformità, anche fisica, tanto più in anni di autoritarismo e dittatura fascista.
 Allora ecco che nelle cartelle cliniche in cui il bambino o la bambina sono chiamati per nome solo all’arrivo nella struttura (oltre a essere foto segnalati e privati dei loro pochi oggetti), poi diventano cose o animali da custodire, di cui si parla con linguaggio burocratico e stereotipato in terza persona. In manicomio finivano per problemi neurologici alla nascita, per un deficit psichico o sensoriale (sordomuti, ciechi), perché figli della guerra o dei bombardamenti, perché per curare la malaria i farmaci portavano a sviluppare psicosi, perché figli di famiglie sbandate, perché orfani, perché non gestibili da genitori non dotati di nessun talento d’affetto. A volte bastava anche soffrire di enuresi notturna o manifestare le prime pulsioni sessuali o uno scarso rendimento scolastico per esser ritenuti soggetti incompatibili con il normale vivere. La famiglia per prima li estrometteva; la scuola li estrometteva; le istituzioni altrettanto feroci non vedevano l’ora di sbarazzarsene, farli internare per non accoglierli mai più. Una strada senza ritorno. Viceversa in certi casi, la situazione dei bambini era di talmente tanta povertà e degrado che il manicomio rappresentava il male minore, quasi un rifugio, la possibilità di frequentare la scuola, ’istituto psico pedagogico che il padiglione per recuperabili aveva. Certo di questi bambini conosciamo una storia parziale tracciata dalla penna di altri: medici, infermieri, assistenti sociali, suore; ognuno con i propri pregiudizi professionali e umani, personificazioni della paura sociale dell’altro, sia pure il più debole della catena; spesso incapaci persino di elementare sensibilità umana.
Allora ecco che nelle cartelle cliniche in cui il bambino o la bambina sono chiamati per nome solo all’arrivo nella struttura (oltre a essere foto segnalati e privati dei loro pochi oggetti), poi diventano cose o animali da custodire, di cui si parla con linguaggio burocratico e stereotipato in terza persona. In manicomio finivano per problemi neurologici alla nascita, per un deficit psichico o sensoriale (sordomuti, ciechi), perché figli della guerra o dei bombardamenti, perché per curare la malaria i farmaci portavano a sviluppare psicosi, perché figli di famiglie sbandate, perché orfani, perché non gestibili da genitori non dotati di nessun talento d’affetto. A volte bastava anche soffrire di enuresi notturna o manifestare le prime pulsioni sessuali o uno scarso rendimento scolastico per esser ritenuti soggetti incompatibili con il normale vivere. La famiglia per prima li estrometteva; la scuola li estrometteva; le istituzioni altrettanto feroci non vedevano l’ora di sbarazzarsene, farli internare per non accoglierli mai più. Una strada senza ritorno. Viceversa in certi casi, la situazione dei bambini era di talmente tanta povertà e degrado che il manicomio rappresentava il male minore, quasi un rifugio, la possibilità di frequentare la scuola, ’istituto psico pedagogico che il padiglione per recuperabili aveva. Certo di questi bambini conosciamo una storia parziale tracciata dalla penna di altri: medici, infermieri, assistenti sociali, suore; ognuno con i propri pregiudizi professionali e umani, personificazioni della paura sociale dell’altro, sia pure il più debole della catena; spesso incapaci persino di elementare sensibilità umana.
 Il bambino non era “centro di un progetto di cura e riabilitazione”, ma intoppo o falla del sistema da isolare, rinchiudere, controllare, foto segnalare all’ingresso, a cui mettere una divisa, contenere mani e piedi, interrogare da parte di un medico più simile a un inquirente che a un guaritore, da catalogare con formule stereotipate senza neanche un reale interesse non già al caso umano ma clinico. Bambini costretti ad affrontare sofferenze sproporzionate rispetto alla loro età, compreso subire contenzioni a uso punitivo ed elettroshock. Solo intorno agli anni ’70 quando la cultura psichiatrica progredisce, la cartella clinica è più dettagliata e attenta alle individualità. Intanto però ci sono stati l’isolamento e la segregazione in applicazione di una legge del 1904. La legge Basaglia è del 1978, ed è il grande spartiacque tra un prima e un dopo. Nessuno può dirsi normale. Specie se messo in condizioni di non esserlo. Per questo, a tanti è toccata in sorte ‘una vita trascorsa senza vivere’. Maria e Giuseppe siamo anche noi.
Il bambino non era “centro di un progetto di cura e riabilitazione”, ma intoppo o falla del sistema da isolare, rinchiudere, controllare, foto segnalare all’ingresso, a cui mettere una divisa, contenere mani e piedi, interrogare da parte di un medico più simile a un inquirente che a un guaritore, da catalogare con formule stereotipate senza neanche un reale interesse non già al caso umano ma clinico. Bambini costretti ad affrontare sofferenze sproporzionate rispetto alla loro età, compreso subire contenzioni a uso punitivo ed elettroshock. Solo intorno agli anni ’70 quando la cultura psichiatrica progredisce, la cartella clinica è più dettagliata e attenta alle individualità. Intanto però ci sono stati l’isolamento e la segregazione in applicazione di una legge del 1904. La legge Basaglia è del 1978, ed è il grande spartiacque tra un prima e un dopo. Nessuno può dirsi normale. Specie se messo in condizioni di non esserlo. Per questo, a tanti è toccata in sorte ‘una vita trascorsa senza vivere’. Maria e Giuseppe siamo anche noi.
Titolo: Maria e Giuseppe in manicomio. I bambini eccitati 
Autore: Ezio Sartori
Editore: Alpes Italia
Dati: 2011, pp., 15.00 €